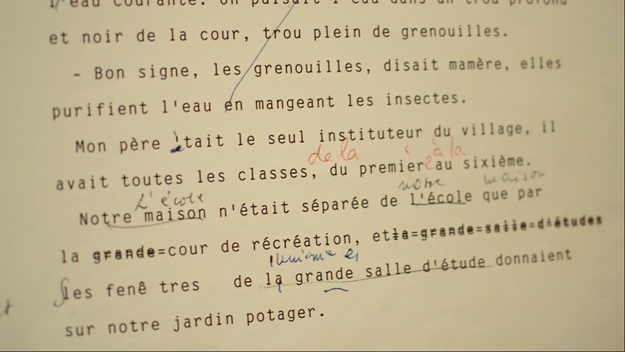
Agota Kristof è una scrittrice che non ha paura. Non ce ce l’ha quando descrive la crudeltà del mondo, quando mette il dito nella piaga dei rapporti umani, quando descrive il distacco e il dolore con i toni di chi ha varcato la soglia di un’altra dimensione ed è tornata a raccontarla, come se non avesse visto altro che quello che si aspettava: il mondo è un posto terribile dove sopravvivere, appena sopportabile nel quale vivere. E gli altri sono o troppo insopportabile vicini o troppo insopportabilmente assenti.
Nei racconti che fanno parte della raccolta intitolata La vendetta, (pubblicato da Einaudi e con la traduzione di Maurizia Balmelli), quel posto terribile è anche rarefatto agli occhi di chi guarda e di chi ha maturato il distacco che viene solo dall’abbandono di ciò che si sarebbe potuto amare. Dico ciò che si sarebbe potuto amare e non ciò che si è amato, perché si tratta di racconti molto brevi e condensati sull’esperienza dell’immigrazione, dell’abbandono (di sé, della terra in cui si è vissuto, delle persone amate, di se stessi persino) e a volte di un ritorno che è ancora più traumatico della partenza in cui non c’è stato nemmeno il tempo di afferrare quello che sarebbe potuta essere la vita in altre circostanze.
La letteratura pullula di racconti ed esperienze di emigrazione con toni che possono anche risultare grotteschi ed esilaranti, penso a Dovlatov a New York, o appassionati e nostalgici come in alcuni romanzi di Nabokov. Anche Agota Kristof è stata un’emigrante. Oggi, che non si riesce a sopportare l’idea che uno scrittore voglia rimanere nascosto dietro un nom de plume e rifiutarsi di partecipare al grande baccano sguaiato dei media e dei social network (e qui penso alla discutibile curiosità dei alcuni quotidiani rispetto alla vera identità di Elena Ferrante), è una sorta di accreditamento ulteriore sapere che uno scrittore ha fatto proprio quelle esperienze sulle quali scrive. Il lettore medio (o mediocre, perché come gli scrittori, anche i lettori possono essere mediocri) vuole conferme, deve essere certo che il dolore, la passione, la sconfitta, persino una menomazione (tanto del corpo quanto dell’anima) sono veri, autentici, come se la cosa reale rendesse più autentico anche il linguaggio che la descrive e così facendo la mettesse su un piano in cui la sospensione dell’incredulità è finalmente in scacco, perché inutile. Finalmente si può credere a qualcuno senza temere che mi stia truffando con una macchinazione, ancorché ben congegnata linguisticamente. E’ quasi ironico che si cerchi l’autenticità in un mondo truffaldino nel quale si viene continuamente messi in scacco dalle menzogne quotidianamente propinate a tutti i livelli. E spesso l’autenticità si pretende proprio dagli scrittori migliori, quelli che attraverso lo straniamento sanno restituire tutto il peso della perdita e del distacco.
La prima volta che lessi Agota Kristof impiegai un giorno intero a riprendermi dalla reazione emotiva che mi aveva provocato. Il libro era Ieri. Lo prelevai dallo scaffale senza sapere niente e niente volli sapere per giorni e settimane e mesi. Altri libri si succedettero ma il ricordo della sensazione di leggere Kristof non me lo sono mai dimenticato. Il dolore mi aveva penetrato in qualche modo al punto tale che portai il libro in borsa dopo che lo avevo finito come un talismano contro i piccoli scorni quotidiani che mi circondavano.
Qualche tempo dopo, un amico mi disse con l’aria tipica di chi ne sa più di te e vuole un po’ scuotere la tua ingenuità (un po’ come fanno gli studiosi di letteratura all’università quando diventano esperti di qualcosa e tu sei solo appassionato di quella cosa) che Kristof aveva lavorato in una fabbrica di orologi ed era un’immigrata ungherese in Svizzera (pare che abbia detto in un’intervista che “due anni di galera in URSS sarebbero stati meglio che cinque anni di fabbrica in Svizzera”). Ci rimasi male. Non che nulla togliesse alla sobria grandezza della sua scrittura, alla feroce eleganza con cui descriveva la crudeltà del vivere l’esistenza, alla necessità di dare una forma al dolore attraverso la prosa raffinata e lineare del francese che come in altri scrittori consente una finezza comune a poche altre lingue.* A volte non si sente la necessità di credere allo scrittore quanto di credere a quello che racconta nel modo in cui lo fa al modo in cui riesce a restituire senso all’esperienza quotidiana del vivere, al senso di impotenza e di scacco che a volte circonda la vita.
Nei racconti de La Vendetta l’esperienza dell’emigrazione è un’esperienza esistenziale nella sua forma più pura e straniante. E’ traumatica la partenza, ma è traumatico anche il ritorno. La cattiveria è come una liberazione e il dolore vissuto non offre molti spunti di compassione altruistica ma semmai rende vendicativi e beffardi e persino inconsapevoli.
Se esiste la possibilità di sopravvivere al dolore, ciò è possibile solo desiderando di ri-appartenere a qualcosa a cui non si è mai appartenuti, solo ricordando il ricordo di vivere un’altra vita. Penso al racconto “Casa mia” in cui la voce narrante di una donna dice
“Sarà in questa o in un’altra vita?
Tornerò a casa.
Fuori gli alberi urleranno, ma non mi faranno più paura, e neanche le nuvole rosse, né le luci della città.
Tornerò a casa, una casa che non ho mai avuto, o troppo lontana perché me ne ricordi, perché non era, non è mai stata veramente casa mia. […]
Così il tempo scorrerà via.
E, sotto le mie palpebre, scorreranno le immagini di quel brutto sogno che fu la mia vita.
Ma non mi faranno più male.
Sarò a casa mia, sola, vecchia e felice.”
*Ovviamente si tratta di un’affermazione discutibile, perché non conosco un numero tale di lingue da mettere a paragone con il francese. Tornerò sull’argomento in un secondo momento e in un altro post.